1 • Nonna Olga
Nonna Olga era mia nonna materna.
È nata a Roma nel 1936, ed è morta nel 2014.
Da quando sono nato – ha sempre vissuto a casa con me e la mia famiglia – insieme a nonno Luigi (suo marito).
Se ripenso alla mia infanzia, ho ricordi felicissimi legati al fatto di essere vissuto insieme a nonna Olga:
- nonna Olga era quasi sempre indaffarata in cucina: nove volte su dieci, era lei a preparare il pasto per tutta la famiglia;
- quando era affaccendata ai fornelli, spesso canticchiava canzoni d’epoca risalenti a chissà quando;
- come tutte le nonne, aveva la smania dell’ordine e della pulizia: si lamentava sempre che casa era piena di «impicci» e si arrabbiava ogni volta che qualcosa era fuori posto… «non sia mai viene qualcuno!»;
- era molto loquace – sia dal vivo che al telefono (telefonava spesso alle sorelle di nonno in Puglia, ad alcune sue cugine, alle sue amiche, a sua nuora, etc);
- dopo che nonno Luigi è andato in pensione (nel 1991), lui e nonna hanno fatto un numero incalcolabile di viaggi, in tutti e cinque i continenti…
- …e infatti nonna era sempre piena di aneddoti da raccontare: ci parlava della Roma di un tempo, di incontri con papi e cardinali, di quando nei mercatini in Cina si faceva capire dai locali (gesticolando e parlando italiano a voce molto alta), di quando in India ha incontrato Madre Teresa di Calcutta (abbiamo in salotto una foto dell’incontro tra lei e i nonni!), di quando viveva in Libia (tra i 4/5 anni e i 10/12 anni, nonna Olga ha vissuto in Libia – all’epoca era una colonia italiana; tornava in Italia solo per le vacanze estive, in nave);
- etc.
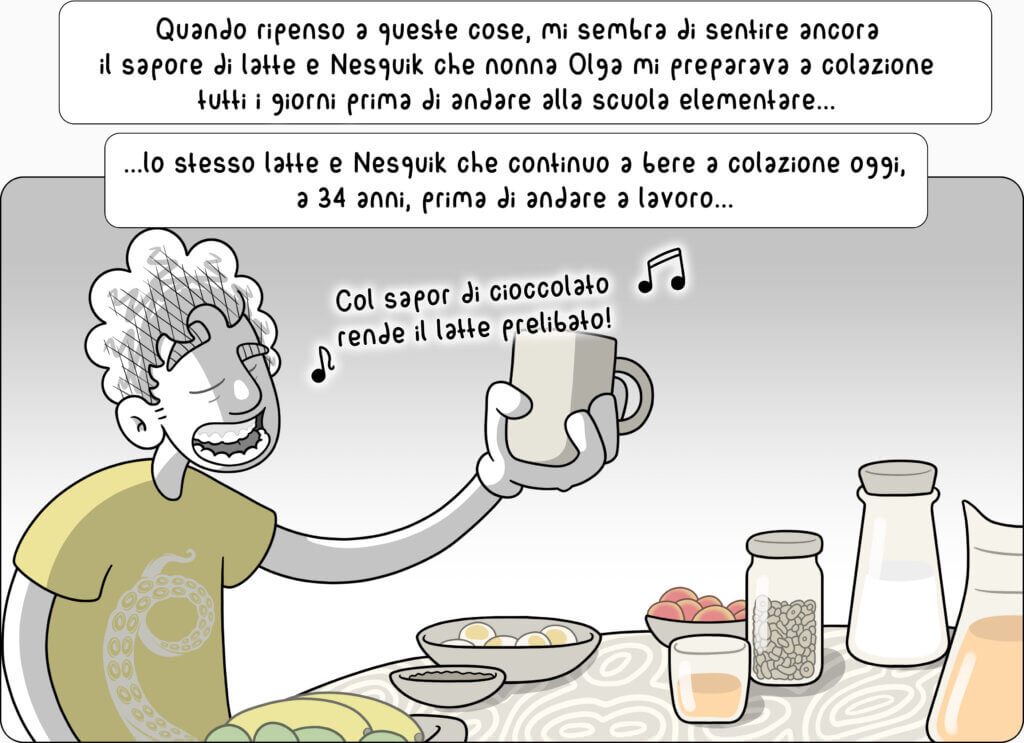
Avevo già raccontato in un’altra pagina del blog che – nonostante nonna Olga fosse una casalinga, e nonno Luigi un magistrato della Corte dei Conti – era lei a “portare i pantaloni in casa”.
Nonna Olga era la legge, l’autorità, «l’alfa e l’omega»…
…nei suoi confronti, ho sempre nutrito un sentimento di venerazione misto a timore reverenziale.
Se litigavo con le mie sorelle, o se c’era qualcosa che turbava la convivenza pacifica tra noi nipoti, nonna Olga era il giudice.
Nonna Olga stabiliva chi aveva ragione e chi aveva torto.
Nonna Olga distribuiva castighi e punizioni.
E, soprattutto, nonna Olga distribuiva sculacciate e schiaffi.
2 • Nonna Olga vs «gli esperti»
Forse la conclusione del precedente paragrafo potrebbe aver fatto storcere il naso a qualcuno.
Noi genitori e genitoresse del terzo millennio siamo circondati da psicologi infantili, pedagogisti illuminati, esperti di mindfulness, terapisti familiari, consulenti olistici, guru, mental coach, influencer del benessere – tutti pronti a dispensare consigli su come crescere figli perfetti senza mai alzare la voce o turbare il loro delicato equilibrio emotivo.
Ebbene sì: nonna Olga ci dava schiaffi e sculacciate.
Che dire?

Intendiamoci.
Nonna Olga non ci picchiava a sangue.
Non si sfilava la cinta.
Non faceva cose da “Telefono Azzurro”.
Però, quando ci comportavamo male, non si faceva scrupoli.
Non erano sculaccioni dati a caso.
Erano precisi, calibrati.
Un’arte tramandata.
Un gesto che chiudeva discussioni e ristabiliva l’ordine, senza bisogno di sedute di autocoscienza o manuali di parenting.
Il più delle volte erano sculaccioni sul sedere.
Ma qualche volta ci scappavano anche schiaffi sulle guance.
Oggi ci chiediamo se i metodi educativi di una volta fossero giusti.
Se non ci abbiano segnato o traumatizzato.
A tal proposito, qualche giorno fa mi è comparso nel feed di Instagram un reel in cui due psicologhe e psicoterapeute dicevano quanto segue:
«Sculacciate educative? Ecco cosa insegnano:
1) che è possibile alzare le mani
2) che è possibile prevalicare sui più deboli
3) che posso imparare a non regolarmi emotivamente, tanto non lo sanno fare neanche i miei genitori
4) che è meglio non sbagliare perché le conseguenze fanno paura
Negli ultimi anni (complice anche il fatto che molti miei amici hanno iniziato a figliare) ho sentito pronunciare queste frasi sempre più spesso.
Ma non è soltanto l’opinione dei miei amici: ho sentito molti «esperti» ripetere la stessa cosa.
Come dargli torto?
Sembrerebbero delle affermazioni sensate…
…se non fosse che c’è una cosa che non mi è mai tornata: io da piccolo ho ricevuto tante sculacciate, eppure non ho mai alzato le mani contro nessuno in vita mia e non ho mai pensato di voler prevalicare sui più deboli, non ho mai avuto sbalzi di umore o esplosioni di ira, e penso di essere sempre stato una persona pacata.
A questo punto, qualcuno potrebbe rispondermi:
- «Sale, non puoi basarti unicamente sulla tua esperienza personale!»
- «Le considerazioni delle psicologhe si basano su dati statistici!»
- «Tu sei un estremo della gaussiana, un’eccezione che non fa media!»
- «La maggior parte dei bambini che hanno preso sculaccioni da piccoli sono diventati persone violente, che non si regolano emotivamente e che hanno il terrore di commettere errori!»
- etc.
Queste obiezioni mi sembrano lecite e sensate.
Il problema però è che non sono solo io ad aver ricevuto gli sculaccioni da piccolo.
Ci sono le mie sorelle, la mia ragazza, tanti amici ed amiche, i miei genitori, i genitori di tanti amici ed amiche, tante persone che conosco… e nessuno di loro corrisponde al profilo psicologico descritto nel reel di Instagram.
A tal proposito, vi vorrei far leggere alcuni commenti che ho trovato sotto a quel reel.
N.b. Ve li riporto così come li ho trovati scritti – quindi se trovate turpiloquio o errori grammaticali… non è colpa mia!
«Mah, credo che la violenza sia un’altra cosa della sculacciata. E credo che noi che qualche sculacciata l’abbiamo presa siamo venuti su meglio di molti “attuali giovani”»
«Io gli sculaccioni li ho presi e ti assicuro che fanno un gran bene, altro che ‘ste stronzate»
«Difatti oggi abbiamo ragazzini che non hanno regole, tanto non ci sono ripercussioni. Uno sculaccione non ha mai rovinato la vita a nessuno, il libertinaggio sì»
«Basta vedere chi non le ha prese come si comporta (maranza coglioni che non hanno rispetto per nessuno)»
«Da piccolo ne ho prese abbastanza ma non ho imparato a prevaricare gli altri e neanche che alzare le mani era consentito. Ho bensì imparato che esiste un limite entro cui i genitori con me dialogano. Se supero quel limite o se mi diverto a cavalcarlo in segno di sfida continua, perdo. Anzi, vinco due ceffoni»
«Io ne ho prese e pure calci nel culo, e mestoli nelle cosce… poche, a dir la verità, ma sono bastate a farmi capire che i comportamenti sbagliati si pagano, io non ho mai alzato le mani verso nessuno»
«Ma va la… mia mamma me le dava quando serviva, e la ringrazio con tutto il cuore!»
«I miei genitori mi hanno riempito di mazzate e li ringrazio, in compenso non ho mai picchiato nessuno e mai picchierò nessuno»
«Quando mio padre mi girò la faccia per il verso, vi assicuro che capii benissimo il perché l’avesse fatto e come girasse il mondo… poi vedi i bimbi Montessori di oggi che a 8 anni non hanno rispetto nemmeno per i genitori, le ricerche sono una cosa, la realtà in molti casi è un’altra»
«Le sculacciate educative servono eccome… Ovviamente una volta erano esagerati, che per ogni fesseria le prendevamo, ma quando ci vuole, ci vuole…»
«Vogliamo paragonare l’educazione dei ragazzi del 1980 e nel 2025 e vediamo se nè miglirata? Ragazzi che non hanno mai preso uno schiaffo che alzano le mani sugli insegnanti…»
«Ne ho prese tante da mia madre, che ammise anche recentemente – quando ne parlammo – di avere esagerato… ma non sono mai diventato un violento o un cinico o un maranza, quindi sono tutte teorie del momento…»
«Mio figlio da piccolo aveva il vizio di tirare le pietre; con molta pazienza gli spiegavo perché non bisognava farlo, e lui continuava. L’ultima volta, dopo aver rischiato di colpire persone, sculacciata forte e mai più tirato pietre»
«E si vede come stanno crescendo i bambini, zero rispetto, questo le ricerche lo dicono?»
«Basta che vi fate un giro fra le classi delle scuole. Mi sa che avete sbagliato ricerche»
«Ho preso tante mazzate educative eppure non ho mai bullizzato nessuno né tantomeno alzato le mani su qualcuno»
Scrollando tra i commenti, ne ho trovato solo uno che era d’accordo col contenuto del post.
Ve lo riporto qui sotto:
«Guarda quanti genitori che abusano dei propri figli spuntano indignati. Vi brucia che siete dei cazzo di violenti senza controllo? Vi piace prendere a schiaffi i vostri fallimenti eh? Più forte, eh, mi raccomando… e quando ti chiede il perché, rispondi “perché sì”, bestia!»
A questo punto qualcuno potrebbe chiedere: «E tu, Sale, da che parte stai?».
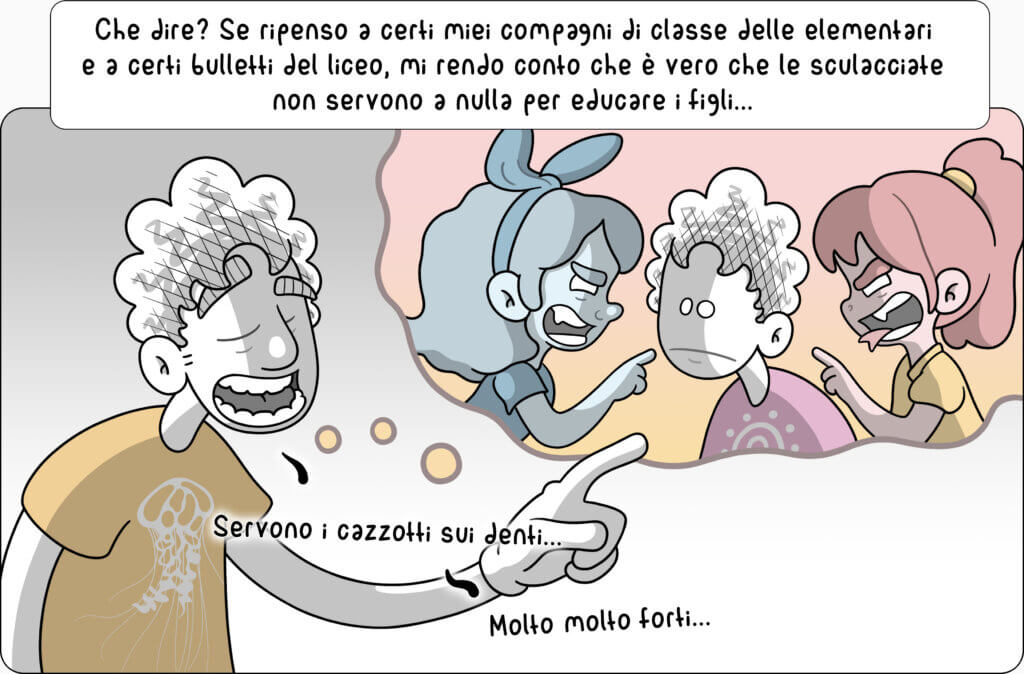
No, dai.
Scherzi a parte.
Io non sto da nessuna «parte».
Non sono uno psicologo.
Non sono uno psicoterapeuta.
Mi rendo conto che la mia esperienza personale non fa statistica.
E non fanno statistica neanche i commenti sotto a un semplice reel di Instagram.
Quel che mi limito a fare – su questo tema come su tanti altri – è pormi domande, leggere libri, rimuginare su quel che ho letto, confrontarmi con le persone di cui ho stima e fare «ricalcola percorso» se giungo a conclusioni sbagliate.
Se qualcuno vuole “dimostrarmi” la tesi per cui le sculacciate rendono i figli violenti, sono tutt’orecchi, e sono molto interessato al tema…
…ma, ad oggi, questa tesi non mi convince.
Come mai?
A me sembra che – a seconda dell’àmbito della realtà che si voglia esaminare – ci sono “professionisti” ed “esperti di un colore politico o di un’altro che dicono che esiste o NON esiste un nesso di causalità, a seconda di quello che fa comodo.
Provo a fare qualche esempio per spiegare ciò che intendo:
- ci sono “specialisti” che dicono che gli sculaccioni portano tuo figlio ad essere violento…
- …ed altri “specialisti” che dicono che gli adolescenti possono giocare serenamente a GTA o altri videogiochi violenti, consumare materiale pornografico, ascoltare musica trap misogina, senza che questo influenzi in alcun modo il loro comportamento;
- ci sono “accademici” che dicono che una battuta su una minoranza è un atto di violenza simbolica che legittima la discriminazione…
- …ed altri “accademici” che dicono che una battuta sul cristianesimo è satira intelligente e critica sociale;
- ci sono “intellettuali” che dicono che se la Chiesa dice che certe condotte sono peccato, sta imponendo la sua morale…
- …ed altri “intellettuali” che dicono che se le aziende (o il sistema scolastico) impongono corsi sull’ideologia gender è progresso;
- ci sono “esperti” che dicono che fumare una canna spinge i ragazzi a provare droghe più pesanti…
- …ed altri “esperti” che dicono che fumare una canna non spinge i ragazzi a provare droghe più pesanti.
Insomma.
Quali “esperti” hanno ragione?
Quando è che si attiva la relazione di causalità e quando no?
Quando è che vale il principio di causa effetto, e quando invece «correlation is not causation»? (cioè «la correlazione non implica causalità»)
A me sembra che in tutti questi dibattiti (sculaccioni in primis) prevalga un principio ideologico a discapito del principio di realtà.
Cosa intendo?
Intendo che non si parte dalla realtà per formulare una teoria su cui basare una pedagogia…
…ma – al contrario – si parte da una ideologia per cercare di adattare forzatamente la realtà ai propri presupposti.
3 • Le sculacciate fanno diventare i figli violenti?
Spero che nessuno abbia interpretato il precedente paragrafo come un «tana libera tutti» per riempire di schiaffi suo figlio.

Non è questo il senso di ciò che ho scritto.
Quello che volevo dire è questo: la psicologia dello sviluppo è una materia molto complessa.
Nella formazione del carattere di una persona agiscono un numero di fattori che – solo a elencarli – si fa notte:
- i genitori (le cose che ci dicono, i messaggi non-verbali che comunicano, il loro sguardo su di noi, i loro gesti, il modo in cui ci hanno manifestato o meno affetto, le loro aspettative su di noi, etc.);
- gli amici (le influenze reciproche, i modelli di comportamento condivisi, il senso di appartenenza o esclusione, il supporto emotivo, etc.);
- la scuola (gli insegnanti, il sistema educativo, le esperienze di apprendimento, il successo o il fallimento accademico, etc.);
- il contesto culturale (le norme sociali, i valori trasmessi, le tradizioni, le aspettative della comunità, etc.);
- i media (la televisione, i social network, i film, la musica, gli influencers, le immagini e i messaggi che plasmano la percezione del mondo, etc.);
- le esperienze personali (i successi, i traumi, le sfide superate, gli incontri significativi, etc.);
- la biologia (le predisposizioni genetiche, la reattività emotiva, l’intensità delle risposte agli stimoli, etc.);
- il contesto economico (le risorse disponibili, la stabilità finanziaria della famiglia, le opportunità o le limitazioni materiali, etc.);
- le figure di riferimento esterne (mentori, allenatori, leader religiosi, modelli positivi o negativi al di fuori della famiglia, etc.);
- gli eventi storici o sociali (guerre, crisi economiche, pandemie, movimenti culturali o politici che segnano un’epoca, etc.).
A me sembra che gli “esperti” che dicono in modo così apodittico che «gli schiaffi insegnano ai figli che è possibile alzare le mani» o «che è possibile prevalicare sui più deboli» iper-semplifichino la questione.
La psiche è estremamente complessa, sfaccettata, stratificata.
E nonostante nell’ultimo secolo gli studî psicologici abbiano fatto enormi passi avanti, ogni psicologo dotato di buon senso concorda nel dire che ciò che conosciamo della mente umana è solo la punta dell’iceberg.
Certamente esistono adulti violenti che sono stati figli di genitori maneschi…
…ma il legame sculaccioni-violenza, onestamente, mi sembra un abbaglio.
Nell’ambito delle fallacie logiche, questo errore viene chiamato «post hoc ergo propter hoc».
Che significa?
È un’espressione latina, la cui traduzione è «dopo ciò, quindi come conseguenza di ciò»: consiste nell’affermare che un evento sia la causa di un altro solo perché gli eventi avvengono in successione, senza giustificare la causalità (per chi volesse approfondire, lo rimando come al solito a questo mazzo di carte).
Dire che uno schiaffo dato da un genitore porta un bambino a diventare violento o a prevaricare sugli altri è una semplificazione che salta troppi passaggi.
Se riprendiamo l’elenco che ho fatto qui sopra – con la miriade di fattori che influenzano lo sviluppo – come si fa ad isolare un singolo gesto – una sculacciata – e dichiararlo causa diretta di un comportamento complesso come la violenza?
Ridurre tutto a una formula lineare – “schiaffo = violenza” – ignora l’intricata rete di influenze che ci rende ciò che siamo.
Non è solo una questione di dati mancanti, ma di umiltà davanti a un sistema – quello della psiche – che sfugge ancora a spiegazioni definitive.
A tal proposito.
Avete presente il reel di Instagram di cui ho parlato nel paragrafo precedente?
Vorrei riportarvi un ultimo commento che ho trovato sotto a quel reel:
«Io sono stato educato anche con sculacciate educative quando esageravo, mentre la mia fidanzata no. Entrambi siamo educati, regoliamo e controlliamo le nostre emozioni. Cosa dicono le ricerche?»
Che dire?
Mi è sembrata una risposta equilibrata.
Sensata.
Ragionevole.
Che tiene conto della complessità della realtà:
- ci sono adulti sani, educati e temperanti che hanno ricevuto sculacciate da piccoli;
- ci sono adulti sani, educati e temperanti che non hanno ricevuto sculacciate da piccoli;
Non ho dati o statistiche alla mano… ma sono abbastanza sicuro che sia vero anche l’opposto, ossia che:
- ci sono adulti violenti e maneschi che hanno ricevuto sculacciate da piccoli;
- ci sono adulti violenti e maneschi che non hanno ricevuto sculacciate da piccoli;
Quello che conta non è la sculacciata in sé… ma il modo in cui viene data:
- se c’è un rapporto di stima nei confronti dei genitori, se i genitori hanno uno sguardo buono sui figli, se i figli stando in casa percepiscono un clima sereno, familiare, se le regole sono chiare e accompagnate da dialogo, se l’affetto è una costante che non viene mai messa in discussione, allora una sculacciata non è traumatica… non lo è stata per me da parte di nonna Olga, né (presumo) lo è stata per le persone nei commenti che ho riportato sopra; in un contesto di fiducia e sicurezza, la sculacciata è un segnale, non una ferita: un modo per dire «qui hai passato il segno», senza spezzare il legame;
- al contrario, se la sculacciata arriva in un ambiente instabile, dove i genitori sono distanti o incoerenti, dove lo sguardo sui figli è severo o giudicante, dove manca un senso di protezione e calore, allora può trasformarsi in qualcosa di molto diverso; può diventare un simbolo di paura, di rabbia repressa o di impotenza, lasciando cicatrici che non si vedono subito; se un bambino cresce percependo che la violenza fisica è l’unico linguaggio per risolvere i conflitti, o se la punizione è imprevedibile e sproporzionata, il rischio è che interiorizzi insicurezza o aggressività.
Non è tanto il gesto in sé, ma il terreno emotivo in cui cade: un terreno fertile di amore lo rende un episodio, un terreno arido lo trasforma in un trauma.
~
Qualche anno fa ho letto un libro di Alexander Lowen (1910-2008), lo psichiatra statunitense che è stato l’ideatore della scuola di psicoterapia nota come «analisi bioenergetica».
Nel testo, Lowen prende in esame tutti i fattori che possono portare allo sviluppo di un disturbo narcisistico; per chi fosse digiuno di studî psicologici, ricordo che il narcisismo non è solo l’eccessiva autostima ma – più in generale – una «corazza caratteriale» che nasce dal distacco tra l’Io (l’immagine che ho di me) e il Sé (la mia emotività): detto in altre parole, il narcisista reprime vulnerabilità e bisogni autentici, costruendo una facciata grandiosa per colmare questo vuoto interno.
Ebbene.
Parlando delle cause del narcisismo, Lowen scrive queste righe:
Da bambini, i narcisisti subiscono quella che la psicoanalisi definisce una grave ferita narcisistica, un colpo alla stima di sé che lascia il segno e modella la loro personalità.
Questa ferita implica un’umiliazione, in particolare implica l’esperienza di essere impotenti mentre un’altra persona prova piacere nell’esercitare su di noi il proprio potere.
Non credo che basti una singola esperienza a formare un carattere, ma quando il bambino è costantemente esposto a umiliazioni in una forma o in un’altra, la paura dell’umiliazione finisce per essere sfruttata nel corpo e nella mente.
(ALEXANDER LOWEN, Il narcisismo: L’identità rinnegata, Feltrinelli, Milano 2013, versione Kindle, 35%)
Ho citato queste righe di Lowen per ribadire ancora una volta che la pagina che state leggendo non è un’«apologia del battipanni».
Il mio intento è semplicemente quello di riflettere su questi temi, cercando quanto più possibile di avere uno sguardo equilibrato.
A proposito di equilibrio, un altro testo molto interessante è il libro «I no che aiutano a crescere» della psicoterapeuta infantile britannica Asha Phillips.
Vi riporto un paio di passaggi del testo che ho trovato significativi:
Le punizioni sono importanti quando si cerca di far valere il proprio no, ma non credo che esista una ricetta valida in tutte le situazioni, e quindi non ho dato loro grande rilievo nel libro. Se siete convinte della vostra decisione, se riuscite a essere in sintonia con vostro figlio, in genere un bambino al di sotto dei cinque anni rispetterà le vostre parole. A volte, naturalmente, potrete aver bisogno di rinforzarle un po’. Le strategie praticabili sono molte: ridurre la tv, mandare il bambino nella sua stanza, confiscargli uno dei giochi preferiti, trattenerlo fisicamente se esagera con i capricci, rifiutarsi di portarlo al parco se si comporta male, e via dicendo. Voi siete nella posizione migliore per sapere cosa funzionerà meglio nella vostra famiglia. Non è la punizione di per se stessa che conta, ma quello che comunicate attraverso il vostro comportamento.
(ASHA PHILLIPS, I no che aiutano a crescere, Feltrinelli, Milano 2013, versione Kindle, 31%)
La mano pesante è controproducente, come lo è perdere le staffe, umiliare il bambino e cercare di imporre la propria volontà con la forza. […] Ma se qualche volta, come succede a tutti i genitori, dite o fate qualcosa che poi rimpiangete, non è la fine del mondo. Il bambino imparerà che siete un essere umano, e non un robot o un angelo, e vedrà magari in una luce più favorevole anche se stesso e i suoi sentimenti appassionati e impetuosi. Se esagerate proprio, può essere molto positivo chiedere scusa. Il modello che trasmettete in questo modo al bambino è quello di una persona che riconsidera quello che ha fatto, si rende conto che forse era sbagliato, lo ammette e chiede scusa. Si aprono così anche per lui queste possibilità. L’importante è non venir meno alla vostra funzione di adulto: capire il bambino e il suo stato d’animo, e al tempo stesso saper pensare cosa è meglio per entrambi. Dovete mantenere il rispetto per voi stesse e fargli capire che il vostro “no” ha una ragione. Non è sempre necessario spiegargliela; è sufficiente che sappiate quello che state facendo. Sono convinta che, in alcune occasioni, per bloccare una escalation di emozioni e di conflitti, uno sculaccione possa essere preferibile a una lunga ramanzina. Molti genitori di questa generazione rischiano di oberare il bambino di lezioni e di spiegazioni a difesa delle proprie scelte.
(ASHA PHILLIPS, I no che aiutano a crescere, Feltrinelli, Milano 2013, versione Kindle, 31%)
Forse qualcuno di voi sarà rimasto interdetto nel leggere un testo in cui una psicologa dice testualmente che «in alcune occasioni, per bloccare una escalation di emozioni e di conflitti, uno sculaccione possa essere preferibile a una lunga ramanzina».
Un’affermazione del genere – ai giorni nostri – è politicamentescorrettissima.
In un contesto culturale come quello odierno, se una frase come quella di Asha Phillips finisse sui social, penso che sarebbe passibile di gogna mediatica.
Eppure, se devo dire la mia, sono contento che ogni tanto qualcuno faccia “coming out” su questo tema (a tal proposito, mi è capitato più volte di sentire l’insegnante e pedagogista Franco Nembrini… e, recentemente, il celebre fumettista Leo Ortolani nel suo «Due figlie e altri animali feroci»).
Ripeto di nuovo: non è questione di essere crudeli con i proprî figli o dispensare cattiverie gratuite (come ricorda la stessa Asha Phillips: «La crudeltà insegna solo a essere cattivi», cfr. Ibidem, 31%)…
…ma capire che le punizioni hanno un valore pedagogico.
Imporre dei limiti a un bambino ha un grande valore pedagogico:
Raramente le concessioni fatte per quieto vivere si rivelano efficaci.
(ASHA PHILLIPS, I no che aiutano a crescere, Feltrinelli, Milano 2013, versione Kindle, 36%)
…e anche le frustrazioni (quando sono ragionevoli) hanno un grandissimo valore nello sviluppo di una psiche equilibrata:
La frustrazione stimola il bambino a fare uso delle proprie risorse, purché naturalmente il “no” sia ragionevole e non generi disperazione.
(ASHA PHILLIPS, I no che aiutano a crescere, Feltrinelli, Milano 2013, versione Kindle, 37%)
Ho trovato molto interessante il libro di Asha Phillips perché non è un concentrato di “riflessioni a tavolino”.
Nel testo, la psicoterapeuta presenta molti casi tratti dalla sua esperienza clinica con persone vere, famiglie vere, figli veri, situazioni vere (mantenendo l’anonimato per rispetto della privacy): non si tratta di teorie astratte, ma di situazioni vissute, di difficoltà affrontate da genitori e figli nel quotidiano.
A titolo di esempio vi riporto poche righe tratte dalla storia di Caroline, una bambina che le ha tutte vinte, perché i genitori sono sempre indulgenti con lei e non la rimproverano mai:
Siccome Caroline, lamentandosi o semplicemente chiedendo, otteneva sempre quello che voleva, crebbe con l’abitudine di averle tutte vinte. Non era abituata a scendere a compromessi o ad aspettare. Quando era in compagnia di altri bambini, non sapeva come comportarsi. Non era capace di condividere le cose e nemmeno di giocare con loro su un piano di parità. Il desiderio della madre di risparmiarle qualsiasi dispiacere si era rivelato controproducente, perché Caroline era incapace di stare con altre persone che non avessero come unica priorità le sue esigenze.
(ASHA PHILLIPS, I no che aiutano a crescere, Feltrinelli, Milano 2013, versione Kindle, 35%)
~
Prima di chiudere il paragrafo, vorrei condividere due chicche che ho scovato su Instagram.
Si tratta di due reel che prendono bonariamente in giro questi nuovi guru dell’“intelligenza emotiva” – quelli che sembrano vivere in un mondo parallelo fatto di calma zen e dialoghi surreali coi figli.
Quegli “esperti” figli dell’ideologia woke che:
- quando tuo figlio ha appena scarabocchiato sul divano con un pennarello indelebile, vorrebbero che ti mettessi in ginocchio davanti a lui, e guardandolo dritto negli occhi, con voce tremula e occhi lucidi, gli dicessi qualcosa tipo:«Tesoro, capisco che il tuo bisogno di espressione artistica sia profondo… posso chiederti il permesso di essere un po’ frustrato per il divano? Dimmi, come posso accompagnarti in questo momento di crescita?»;
- se il tuo bimbo lancia un piatto di spaghetti contro il muro durante la cena, ti consiglierebbero di inspirare profondamente e sussurrare: «Vedo che stai esplorando la tua relazione con il cibo. Vuoi che validiamo insieme questa emozione o preferisci esprimere la tua rabbia con un altro lancio?»;
- quando tuo figlio urla ininterrottamente al supermercato perché vuole un pacco di caramelle, si aspettano che ti sieda per terra accanto a lui e gli dica con tono da meditazione: «Sento la tua passione per le caramelle, amore. Possiamo co-regolarci con un respiro consapevole o vuoi che negoziamo un’alternativa emotivamente sostenibile?»;
- se per caso alzi la voce dopo ore di capricci, ti guarderebbero con disapprovazione, suggerendo: «La tua energia sta sopraffacendo il suo spazio emotivo. Perché non provi a cantargli una canzone sulla frustrazione per ristabilire l’armonia?»
Il primo dei due reel è di un papà…
…il secondo è di una mamma (Olivia J Owen, mamma di sette figli):
4 • Le sculacciate di Dio
Non ricordo l’occasione, ma qualche anno fa mi è capitato di leggere uno stralcio in cui un “teologo” (*) diceva qualcosa del genere:
Un Dio che castiga meriterebbe di essere negato.
(*) (ricordavo fosse Enzo Bianchi, ma cercando online non ho trovato la citazione precisa… c’è questo articolo sul suo blog, ma non contiene il virgolettato esatto… insomma, in assenza di prove, diciamo a pronunciare questa frase è stato un generico “guru spirituale” del mondo cattolico secolarizzato)
Questa affermazione mi ha lasciato un po’ interdetto.
Noi tutti – io per primo – abbiamo un bias radicato, per il quale tendiamo ad associare la parola «castigo» a qualcosa di brutto, di spiacevole, di crudele.
È più forte di noi: appena sentiamo parlare di «punizione», ci immaginiamo un’azione ostile, un’imposizione che opprime.
Tra l’altro, non è solo una questione legata a Dio; pensate a come guardate, in generale, a chi ha il compito di vigilare: che sia un genitore, un professore o le «guardie» (il nemico numero uno nel microcosmo di Zerocalcare), chi esercita un’autorità correttiva diventa subito il “cattivo”.
È come se il castigo, nel nostro immaginario, fosse sinonimo di negatività… qualcosa da temere… o da cui scappare…
Eppure – come dicevo in un’altra occasione qui sul blog – la parola «castigare» viene da «castum + agere», cioè «rendere puro».
«Castigare» non significa «infliggere una sofferenza per il gusto di farlo», ma «condurre verso la purezza, correggere per migliorare».
Oh, famo a capisse.
Mi rendo conto che tanti esempî di autorità esercitata malamente, abusi di potere, e distorsioni varie hanno contribuito a caricare questa parola di un peso negativo…
…ma vi invito a fermarvi un secondo sull’etimologia e a riconsiderarne il senso.
Questa cosa che ho appena detto si lega a doppio filo col discorso riguardo alle sculacciate di nonna Olga: se non riusciamo a concepire una sculacciata sul sedere di un figlio, allo stesso modo ci risulterà difficile immaginare uno “scappellotto” da parte di Dio Padre.
Eppure Dio opera anche in questo modo.
Intendiamoci.
Certamente Dio parla quando siamo nella pace e nella gioia – e lo fa con tenerezza, con dolcezza, con misericordia, consolando il nostro cuore (fratm Ignazio docet!)…
…ma Dio parla anche attraverso le croci, le sofferenze e gli “sculaccioni” che la vita ci riserva:
Dio ci parla in molti modi: attraverso la sua Parola, per mezzo delle persone con le quali viviamo, con le circostanze più svariate, felici o dolorose. E sono queste ultime le maggiormente temute: sappiamo fin troppo bene che Dio ha qualcosa da dirci tramite la prova, la malattia, la morte, la contraddizione. Se questo timore pervade ancora il nostro cuore, significa che solo la collera di Dio è presente al nostro spirito, che non siamo ancora discernere, dietro il segno apparente della collera, l’amore infinito di Dio.
(ANDRÉ LOUF, Sotto la guida dello spirito, Qiqajon, Magnano (BI) 2005, p.13)
Con questo NON voglio dire che ogni male che ci capita è un castigo divino!
Non è così!
Il male è un mistero, ed è sempre un atto blasfemo dire a qualcuno: «Ti è successa questa cosa brutta perché Dio…», «Questo dolore è un segno di Dio che ti dice che…» o simili (per chi volesse approfondire, lo rimando alla pagina che avevo scritto nel lontano 2019 dal titolo «Se Dio è buono, perché c’è il male nel mondo?»)…
…però, se ripenso alla mia vita, io ho ben chiare tante sofferenze che mi sono arrivate come “sculacciata da parte di Dio” rispetto a strade sbagliate che avevo imboccato.
Erano le sculacciate di un Genitore Saggio, che – giustamente – voleva correggere il tiro della mia vita.
Lì per lì mi rodeva il culo e bestemmiavo… ma col senno di poi riconosco che mi hanno fatto molto bene!
Per dire queste cose, secondo me, è sufficiente usare il buon senso…
…ma se qualcuno volesse un riferimento biblico come contro-prova di ciò che sto dicendo, ce ne sono fin troppi (la parola «castigo» e suoi derivati compare più di 100 volte, tra Antico e Nuovo Testamento… e molte volte il soggetto di questo verbo è Dio stesso):
Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così il Signore, tuo Dio, corregge te.
(Deuteronomio 8,5)
Se nemmeno a questo punto mi darete ascolto, io vi castigherò sette volte di più per i vostri peccati.
(Levitico 26,18)
Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d’uomo e con percosse di figli d’uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore.
(2 Samuele 7,14-15)
Chi ha formato l’orecchio, forse non sente?
Chi ha plasmato l’occhio, forse non vede?
Colui che castiga le genti, forse non punisce,
lui che insegna all’uomo il sapere?
(Salmo 94,9-10)
Figlio mio, non disprezzare l’istruzione del Signore
e non aver a noia la sua correzione,
perché il Signore corregge chi ama,
come un padre il figlio prediletto.
(Proverbi 3,11-12)
Insomma.
Se dovessimo usare con Dio la stessa logica con cui certi “esperti” demonizzano le sculacciate, dovremmo convenire che Dio è un pessimo genitore, dal momento che non ci risparmia dolori, sofferenze e pali-in-faccia.
E infatti molte persone pensano esattamente questo, cioè che Dio sia un genitore dimmerda.
E prima lo bestemmiano.
Poi lo rifiutano.
E infine lo negano.
Il problema, però, è che se si toglie di mezzo Dio, la vita è veramente una merda, perché non c’è più nulla che possa offrire un po’ di senso a quelle sculacciate che tante volte ci arrivano “dalla vita”.
E ci troviamo a navigare a vista, in un mare di «perché?» che non trovano risposta.
Senza Dio, quelle sculacciate diventano solo “schiaffi casuali” da parte di un universo indifferente alle nostre inquietudini esistenziali.
Tra l’altro – come se tutto questo non bastasse – c’è un altro aspetto problematico che ci frega.
Prima citavo Asha Phillips che parlava del ruolo pedagogico della frustrazione.
A me sembra che nel contesto in cui viviamo siamo un po’ tutti (io per primo!) disabituati a gestire la frustrazione: vogliamo capire tutto subito, vogliamo avere il manuale d’istruzioni della vita con le risposte belle pronte, vogliamo che mamma e papà – se si arrabbiano con noi – ci spieghino il perché di quell’urlo, di quella sculacciata, di quella punizione…
…mentre invece Dio non funziona così.
Tante volte, Dio ci dà una sculacciata e poi ci lascia lì, in silenzio, senza troppi panegirici.
Ci lascia arrabbiati.
Frustrati.
Liberi di decidere se tenere il broncio in eterno o fare qualcosa di quello sculaccione che “la vita” ci ha riservato.
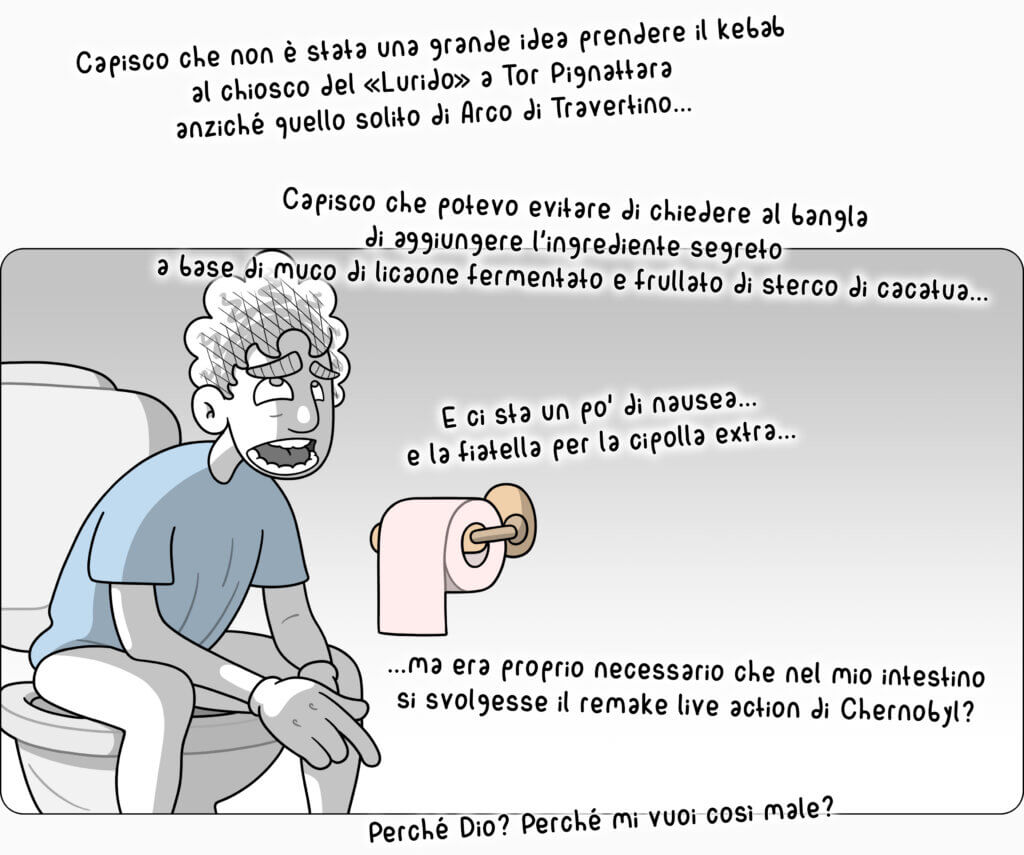
La Chiesa, una volta all’anno, all’interno della liturgia del Venerdì Santo, propone ai fedeli un gesto spiazzante: l’adorazione della croce.
Non è l’adorazione «del crocifisso».
Non è l’adorazione di Gesù che – porello – ti guarda con quegli occhi da cane bastonato, appeso alla croce.
No. È l’adorazione «della croce».
Nuda.
Cruda.
Spoglia.
Spigolosa.
Quel pezzo di legno che non fa sconti a nessuno.
E tu stai lì.
In silenzio.
Che contempli – insieme a quella di Cristo – anche la tua croce.
La tua frustrazione.
I pali in faccia che la vita ti ha dato.
Le sculacciate che ti sono arrivate, senza che Dio abbia «negoziato con te un’alternativa emotivamente sostenibile».
A tal proposito, vorrei chiudere il paragrafo con un paio di stralci della mistica e assistente sociale francese Madeleine Delbrêl (1904-1964):
Se tutte le grandi virtù evangeliche possono, con la grazia di Dio, essere messe in cantiere dalla nostra buona volontà, esse non sono sé stesse – e non sono quelle di Gesù – che quando lo Spirito di Gesù che le comunica pienamente, dando loro dimensioni nuove per mezzo della croce e soltanto per mezzo della croce.
I cristiani pregano in varie maniere davanti al loro crocifisso, più o meno spesso l’onorano, lo contemplano, si mettono alla sua scuola.
Ma una volta l’anno, il venerdì santo, la Chiesa convoca i cristiani a una preghiera liturgica che non si chiama né omaggio né contemplazione né lezione della croce: si chiama adorazione della croce.
[…]
Essa ci appare velata da qualcosa che le toglie, ai nostri occhi, la sua forma, le sue proporzioni, la sua misura. Oppure sembra fatta di prodigi d’incoerenza. O sembra uscire come un’ombra falsa da una luce falsa. Oppure viene a costringerci nella contraddizione.
Il mistero che ci propone, fin dal suo avvicinarsi, «rinnega» qualcosa di vitale nel nostro essere umano, nel nostro essere di uomo cristiano. Il mistero della croce «mortifica» assolutamente, secondo le apparenze, qualcosa senza cui sappiamo che non potremmo più vivere, l’essenza della nostra vita umana; senza cui non potremmo più agire da uomini.
In realtà, essa annienta una delle cose che fanno di noi non un uomo ma l’uomo che noi siamo. Tutte le Beatitudini, le virtù insegnate da gesù Cristo, i consigli che ha dato e le promesse che ha fatto portano ciascuna in sé una via al mistero della croce. Ciò avviene perché la Buona Novella – tutta intera – è la Buona Novella della carità resa possibile e che rimane possibile per mezzo della croce e nella croce.
Tutto il Vangelo è per la carità. Ma senza la croce che racchiude il nome stesso di Gesù, noi saremmo di fronte alla carità la sua maggiore contraddizione: degli estranei.
(MADELEINE DELBRÊL, da alcune note scritte secondo l’intenzione dei suoi gruppi nel 1956, in MADELEINE DELBRÊL, La gioia di credere, Gribaudi, Torino 2012, p.131)
Si tratta di nascere bene ogni volta che moriamo,
di nascere un poco quando moriamo un poco,
e di nascere molto quando moriamo molto.
Si tratta, in questo ripetuto incontro con la morte,
d’imparare a incontrare la vita.
[…]
Si tratta di aprire i nostri ochi di fede
là dove i nostri occhi ci vengono meno.
(MADELEINE DELBRÊL, “Tu morirai di morte”, in MADELEINE DELBRÊL, La gioia di credere, Gribaudi, Torino 2012, p.152)
Conclusione
Ho il timore che – leggendo questa pagina – qualcuno di voi possa aver pensato che io non prenda seriamente il lavoro di psicologi e psicoterapeuti.
Ebbene, non è vero.
A tal proposito, faccio mie le parole che Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) ha scritto al termine di un suo famoso saggio:
In questo libro […] sento di avere qualche volta dato l’impressione di prendere in burletta il lavoro scientifico serio.
Ciò era il contrario della mia intenzione.
Io non discuto con lo scienziato che spiega l’elefante, ma col sofista che lo spiega senza averlo visto.
(GILBERT KEITH CHESTERTON, L’uomo eterno, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2023, versione Kindle, 96%)
In una pagina del blog di un paio di anni fa, avevo citato il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han (classe ’59).
Nel suo libro La società senza dolore, Han fa un’analogia tra la società contemporanea e la fiaba «La principessa sul pisello» di Hans Christian Andersen.
Come ricoderete, nella fiaba, la principessa è talmente sensibile da percepire un piccolo pisello sotto numerosi strati di materassi.
Han paragona questa ipersensibilità della principessa alla società moderna, sempre più intollerante al dolore e al disagio, anche quando esso è minimo.
Ebbene.
Premesso che – come scrivevo sopra – io non sono uno psicologo, uno psicoterapeuta o un esperto di psicologia dello sviluppo (ho letto libri e ho fatto qualche esame all’università su questi temi… ma – veramente – poco e niente)…
E premesso che in questa pagina del blog – ancor meno che in altre – non ci sono “risposte”… ma solo “pensieri sparsi” sui quali ultimamente ho rimuginato…
…secondo me, la critica di Han si potrebbe estendere anche alle teorie degli “esperti” di cui parlavo sopra – così attenti a condannare sculacciate, scappellotti, e ogni forma di correzione, frustrazione e fastidio che un bambino possa sperimentare quando viene rimproverato.
Insomma, mi chiedo: se si seguono i consigli di alcuni di questi «guru del parenting» non si rischia di tirar su bambini che poi faranno fatica a confrontarsi con le inevitabili asperità della vita – come la principessa della fiaba, che non tollera il minimo disagio?
Lascio aperta questa domanda.
sale
(Primavera 2025)
- ASHA PHILLIPS, I no che aiutano a crescere, Feltrinelli, Milano 2013
- ALEXANDER LOWEN, Il narcisismo: L'identità rinnegata, Feltrinelli, Milano 2013
- DONALD WINNICOTT, Il bambino, la famiglia e il mondo esterno, Magi, Roma 2005
- BYUNG-CHUL HAN, La società senza dolore: Perché abbiamo bandito la sofferenza dalle nostre vite, Einaudi, Torino 2021
- ANDRÉ LOUF, Sotto la guida dello Spirito, Qiqajon, Magnano (BI) 2005